II manuale dell’uomo per bene
Quando il vecchio ordine senatoriale della repubblica romana sembrò entrato nella sua ultima e definitiva crisi, con l’instaurazione del potere personale di Giulio Cesare e con le difficili vicende che seguirono all’uccisione del dittatore, Cicerone, che la tradizione avrebbe consacrato come il più grande oratore romano, uomo legato alla classe senatoriale, si trovò tagliato fuori dalla vita politica attiva. In quei momenti di tristezza, ma anche di libertà dagli impegni pubblici, Cicerone tornò agli studi filosofici, che aveva coltivato direttamente ad Atene, alla scuola dei maggiori maestri del tempo, e scrisse ampiamente di filosofia: riprendeva idee e dottrine greche, ma le esprimeva in lingua latina, applicandole alla tradizione storica romana. L’ultima delle opere filosofiche di Cicerone, scritta nel 44 a.C., dopo la morte di Cesare, è un piccolo trattato indirizzato al figlio che studiava filosofia ad Atene. Questo trattato “Sui doveri” (De officiis, appunto) è un manuale che contiene le regole di vita sufficienti per dirigere il comportamento di un buon cittadino, di un uomo rispettabile, sostanzialmente convinto di essere onesto e anche preoccupato di dimostrarlo, partecipe di tutti i criteri di giudizio delle classi alte del mondo romano.
Cicerone riconosceva apertamente di ispirarsi all’opera “Sul dovere” di un celebre filosofo stoico, Panezio di Rodi, vissuto circa un secolo prima. Panezio aveva trascorso molti anni a Roma e si era legato di profonda amicizia con P. Scipione Emiliano e con i membri del circolo aristocratico ed ellenizzante che si riuniva intorno a lui. Il concetto di dovere, che dava il titolo a una delle sue opere, era certamente concetto stoico: ne aveva trattato il fondatore della scuola, Zenone, in un’opera apposita, forse anche Cleante e Crisippo avevano dedicato un’opera a esso, e comunque il concetto e il termine erano sempre presenti nelle discussioni stoiche. L’invenzione del termine ‘dovere’ veniva fatta risalire allo stesso Zenone, che lo aveva usato per indicare i tipi di comportamento razionali, quelli, cioè, che nella dottrina stoica conducono alla virtù. E qui si era subito accesa la discussione. Zenone aveva considerato la virtù fine a se stessa e aveva semplificato la complessa sistematica delle virtù dell’etica aristotelica. Ma quel che si era eliminato dal lato delle virtù rischiava di risorgere dal lato del dovere: ci sono comportamenti razionali, irrazionali, indifferenti; dove collocare il confine tra razionali e irrazionali, da una parte, e indifferenti, dall’altra? ossia, che atteggiamento tenere verso comportamenti che sono approvati o disapprovati dalla società, ma che non sembrano direttamente collegati con la virtù? L’etica stoica, radicale nella teoria della virtù, pronta a tagliar corto con una classificazione dei comportamenti raccomandabili (cioè delle virtù) che tenesse troppo strettamente conto della stratificazione sociale, rischiava di riassorbire tutti í precetti del ben vivere sociale proprio nella teoria del dovere. Si dovette discutere su questo punto già nell’antica Stoa. Cleante raccomandava, con una certa preoccupazione, di non fare della precettistica minuta, e di riportare sempre tutti i doveri alla loro fonte filosofica generale. E Crisippo, il capo della Stoa nel III sec. a.C., quello che chiamavano il secondo fondatore dello stoicismo, pensava che la illustrazione dei doveri dovesse partire dai principi stessi della natura, e ribadiva le tesi zenoniane, che la virtù è fine supremo dell’uomo, bene sommo, e non, come per l’etica aristotelica, una parte del bene, cioè un mezzo per raggiungere la perfetta miscela di tutti i beni di ogni tipo. Tuttavia Crisippo sentiva in qualche modo il bisogno di gettare un ponte tra l’ideale di vita stoico e la realtà sociale nella quale l’uomo si trovava a vivere, fatta di compiti speciali, di occupazioni quotidiane, di preoccupazioni non sempre orientate verso la virtù, di stratificazioni sociali. A questo serviva appunto la teoria del dovere.
Crisippo cercò di elaborare una teoria del dovere che, pur tenendo fede al rigorismo stoico, fosse abbastanza elastica da adattarsi alla realtà sociale. Egli distinse tra i doveri perfetti e quelli imperfetti: i primi sono quelli direttamente collegati alle virtù, sono compiuti in se stessi, in essi non ha importanza il compimento esterno e
tecnico delle operazioni, ma conta soprattutto l’intenzione, mentre nei doveri imperfetti, che sono comportamenti indirettamente collegati con la virtù, conta il compimento. Comunque quello che importa è la subordinazione dei doveri imperfetti ai perfetti, in modo che l’intenzione ultima sia la virtù, perché da questo punto di vista si giudica l’uomo, e, quando non si persegue la virtù, qualsiasi prestazione nel campo dei doveri imperfetti è un errore, un elemento negativo. Una vasta sezione della vita civile veniva così ricuperata nella sfera morale, perché una serie assai ampia di comportamenti poteva ora essere compresa con il concetto di dovere imperfetto e poteva essere interpretata come un mezzo necessario per stabilire le condizioni minime di possibilità della stessa virtù. Naturalmente ora si affacciava un problema di fondo. Nel momento in cui si riconoscevano nei beni esterni condizioni necessarie per la realizzazione della virtù, anche se non oggetti diretti e primari di apprezzamento, bisognava dimostrare che la realizzazione a ogni costo della virtù non avrebbe condotto alla distruzione di quelle stesse condizioni esterne. Per esempio, il perseguímento della virtù a ogni costo, come prescrive la morale stoica, non avrebbe compromesso il comportamento dell’uomo d’affari che mira al guadagno, del politico, del guerriero, che pure sono necessari per tener in piedi le strutture che costituiscono il tessuto della vita sociale e le condizioni esterne della stessa virtù? Una problematica di questo genere diede vita nella scuola stoica a discussioni sottili a non finire. Crisippo parò la difficoltà su due piani. Da un lato insisté sul principio che bisogna valutare il comportamento complessivo del saggio e tener conto soprattutto delle intenzioni; dall’altro cercò di mostrare come nell’ordine naturale il massimo della virtù rende anche possibile il massimo di socialità.
.
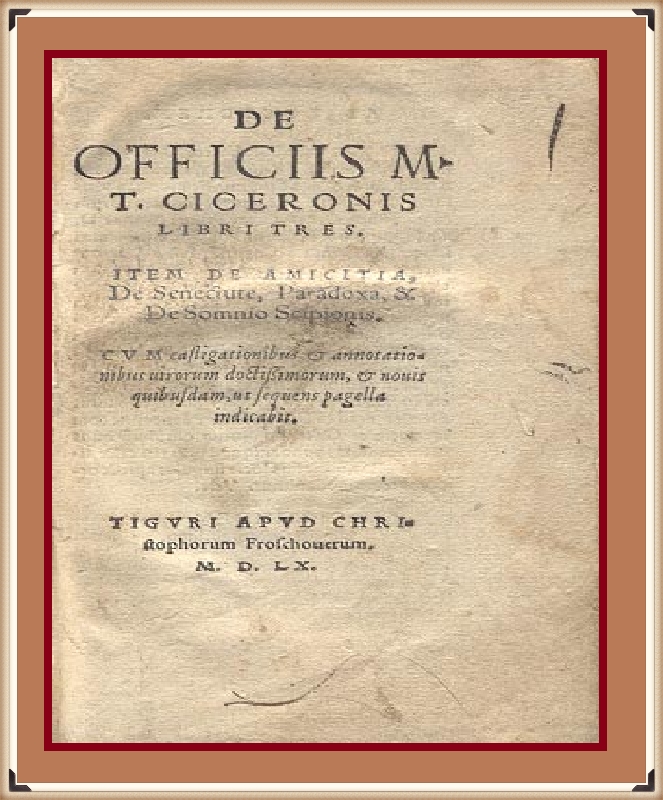
.
LA PENETRAZIONE A ROMA DELLA CULTURA GRECA
Panezio era stato scolaro di Diogene di Babilonia e succedette, nella guida della Stoa, ad Antipatro di Tarso, due eminenti campioni della casistica del dovere. Ma Diogene era stato (con l’accademico Carneade e con il peripatetico Critolao) uno dei tre filosofi mandati come ambasciatori da Atene a Roma nel 156-155 a.C. Quell’ambasceria fu un episodio importante nella storia della cultura antica. I tre filosofi greci suscitarono interesse e preoccupazioni a Roma, ma segnarono l’inizio di stabili relazioni tra Roma e i maggiori uomini di cultura greci. Filone di Larissa, un seguace di Carneade, si stabilì a Roma e fu il primo maestro di filosofia di Cicerone; un allievo di Diogene, Panezio, divenne intimo di Scipione Emiliano. E Panezio fu anche il filosofo stoico che sancì l’effettivo abbandono del rigorismo originario della scuola, sviluppando la dottrina crisippea dell’ordine naturale. Nel circolo di Scipione, insieme con Panezio, c’era Polibio, il grande storico greco che cercò di spiegare in una prospettiva universale il fenomeno romano. Polibio vide certamente in Roma una potenza giovane, ancora dotata delle virtù originarie perdute dalle antiche civiltà ellenistiche; ma fu anche colpito dalla superstizione romana, da quella forma di religiosità popolare e minuta capace di controllare il comportamento delle plebi. In fondo, la cultura greca, così razionalistica e illuminata, aveva sbagliato i conti, aveva perso i contatti con il mondo reale, capace, com’era, di parlare solo a uno Stato di filosofi.
POLITICA E FILOSOFIA
Anche Panezio dovette esser preso in questo giro di problemi. La tradizione vide in lui lo stoico che si era riavvicinato a Platone e Aristotele: in realtà egli rifiutò il privilegiamento zenoniano della virtù, tornò a fare della virtù un mezzo per raggiungere un bene più complesso, del quale fanno parte il piacere e i beni esterni. Platone e Aristotele gli insegnarono anche a scorgere nella religione popolare quel mezzo di controllo sociale che l’amico Polibio vedeva all’opera nella società romana. Tuttavia egli fu il consigliere culturale dei leaders dell’imperialismo cosmopolitico romano. Se voleva fare una politica mondiale, Roma doveva uscire dalla prospettiva superstiziosa italica, doveva seguire il filo conduttore di un ordine mondiale nel quale tutti potessero trovare il loro posto. Gli Scipioni erano imbevuti di spirito illuministico, sapevano che cos’era la superstizione e non ne ignoravano la funzione sociale; ma nell’ordine universale si doveva trovare un posto anche per quelli ai quali dice qualcosa solo la superstizione. In questa prospettiva costruire uno Stato che abbia come fine ultimo la virtù sarebbe follia, perché dietro la superstizione ci sono i tumulti popolari, la violenta storia agraria di Roma antica, l’economia schiavistica, e, dall’altra parte, una classe di nobili che vuol sì costruire un grande impero, ma che vede in esso potenza, ricchezza, beni utili. Il mito romano delle antiche virtù, la superstizione popolare, le lotte sociali, la potenza ascendente della classe senatoriale: erano questi i termini del problema filosofico di Panezio. E il suo tentativo fu quello di mostrare che la pratica della virtù è il mezzo migliore per conciliare tutte queste cose, il cammino sicuro attraverso un ordine naturale nel quale stanno tutti, ciascuno al suo posto. Alle diffidenze del vecchio Catone, Panezio opponeva una concezione nella quale proprio la via della virtù porta a grandezza e opulenza che vanno ben al di là del mondo agrario italico. Nella morale paneziana è davvero ricuperato il riferimento, che era stato di Platone e di Aristotele, alla gerarchia sociale, anche se ora il quadro è ispirato al cosmopolitismo stoico e non alla polis classica. E’ rimasto della filosofia stoica il riferimento diretto alla natura, anche se ora il contatto con la natura non è più un fatto individuale del sapiente, in qualche misura polemico con la civiltà, ma è il quadro orientativo di una politica che superi i limiti stretti del mondo italico.
Circa un secolo più tardi, quando Cicerone scriveva il “De officiis”, prendendo a modello Panezio, l’impero romano non aveva realizzato l’ordine cosmico del filosofo di Rodi, non aveva risolto i problemi del mondo italico; anzi aveva posto nuovi problemi, che ripresentavano i vecchi problemi di Roma e dell’Italia in una nuova luce. La violenza della politica romana sembrava aver distrutto il progetto di fare della società romana la patria degna di un filosofo stoico, la sede nella quale la sapienza solitaria dello stoico può conciliarsi con i beni della vita associata, con le ricchezze, con l’esercizio dell’oratoria e con il gusto delle cose belle. Eppure Cicerone pensa ancora che i doveri quotidiani, le regole che devono guidare le faccende della vita di un uomo per bene debbano ispirarsi all’ordine naturale nel quale la virtù mette capo a una vita sicura e agiata.
L’UOMO, ESSERE RAZIONALE
Al di là delle lotte e dei contrasti l’uomo è essenzialmente un essere razionale, cioè fatto per vivere in armonia con í propri simili. La convivenza razionale si realizza attraverso le famose quattro virtù cardinali, che sono il miglior modo per produrre la cooperazione universale tra gli uomini. La giustizia impedisce che gli uomini si danneggino a vicenda, salvaguarda gli interessi comuni dell’umanità e li rende compatibili con gl’interessi privati, che hanno la loro garanzia nella proprietà privata. In natura non c’è proprietà privata, ma sono previsti i mezzi per acquistare la proprietà privata e per tutelarla. Tuttavia, pur nella tutela dei propri interessi, gli uomini devono scambiarsi reciproche prestazioni, mettendo abilità e risorse al servizio del consorzio umano. La buona fede, cioè la scrupolosa osservanza di
promesse e contratti, è il fondamento della giustizia. Contro la giustizia peccano quelli che, spinti dall’ambizione, cercano di superare la misura (e Cesare è un buon esempio di ambizioso, per Cicerone), o quelli che per negligenza, pigrizia, eccessiva attenzione per le proprie occupazioni o per il proprio interesse non intervengono attivamente nella realizzazione della giustizia pubblica o nella lotta contro l’ingiustizia. La fortezza è interpretata da Cicerone soprattutto come coraggio civile, come dovere di esercitare le pubbliche funzioni con oggettività, senza insuperbirsi, come senso della misura sia nella buona sia nell’avversa fortuna. A questo senso della misura presiede anche la temperanza, che assicura soprattutto il decoro dell’uomo per bene. Il decoro consiste nella proprietà dei modi, che non devono essere eccessivi in generale e che devono essere adatti alla parte che si ha nel tutto. La proprietà dei modi va dal dominio delle emozioni, al comportamento esterno, all’uso del linguaggio, all’abitazione. Per Cicerone tutti i doveri sono condizionati dalla parte che si ha nella società, sicché tra le virtù senza dubbio la giustizia è la più importante.
VIRTÙ E UTILITÀ
Il comportamento umano deve dirigersi non solo in base al complesso di doveri che derivano dalle virtù, e che costituiscono quella che Cicerone chiama l’onestà, ma anche in base all’utilità. Come abbiamo visto, questo era uno dei punti deboli della morale stoica; ma, sulle tracce di Panezio, Cicerone pensa di poter eliminare in linea di principio il conflitto tra onesto e utile. Cicerone parte sempre dalla concezione dell’uomo come essere fatto per stare in società con gli altri uomini sulla base dei dettami della ragione e della pratica della virtù. La maggior utilità che l’uomo può ricavare e il maggior danno che può subire derivano proprio dalle buone e cattive relazioni con i suoi simili: e solo la pratica delle virtù procura buone relazioni. Questo vale per i singoli come per gli Stati. La pratica della virtù porta alla popolarità, al potere, alla gloria i singoli, come assicura il giusto dominio, la fedeltà degli alleati agli Stati: la crisi della repubblica romana, cominciata già prima di Silla, è dovuta proprio al perseguimento dell’utilità senza giustizia. E al perseguimento del proprio utile fuori dell’ordine universale della giustizia si può far risalire l’altro grande male che mina la repubblica romana: le pretese eccessive della plebe, la politica delle leggi agrarie e del condono dei debiti, tutti progetti che minacciano la proprietà privata, uno dei grandi sostegni dell’ordine universale.
L’OTTIMISMO CICERONIANO
Il quadro che emerge dal manuale di Cicerone è piuttosto ottimistico: l’uomo per bene deve praticare sempre le virtù, nutrire il senso di solidarietà con gli altri uomini, tener presente che il bene pubblico è superiore al bene privato, mantenere il decoro nel comportamento interiore, in quello esterno, nel parlare, nel vestire, nella abitazione; gliene verrà la sicura protezione dei suoi beni, la difesa della sua proprietà, la popolarità, il potere e financo la gloria, avrà schiavi con i quali potrà perfino permettersi di essere umano, avrà amici e serenità d’animo. Eppure nel discorso di Cicerone non mancano le note inquietanti: egli sa che il suo modello, Panezio, ha scritto circa cent’anni prima, che nel frattempo la repubblica romana ha visto crescere la grande ricchezza finanziaria, il potere personale dei capi, reso possibile da quella ricchezza e dalle imprese militari, ha conosciuto le lotte per le leggi agrarie, i problemi posti dall’economia schiavistica. A Cicerone la filosofia di Panezio e la politica degli Scipioni potevano ora sembrare una realtà del buon tempo antico, minacciata dalla decadenza presente, anche se una realtà non era mai stata, perché l’etica paneziana era stata non la descrizione di una realtà, ma la risposta a problemi reali. Panezio aveva attinto a piene mani alla cultura greca per cercare di formulare i problemi romani, e in generale del mondo ellenistico, in chiave universale; e dietro c’era il senso di una politica precisa, cioè il pensiero che, proiettati su scala mondiale, i problemi di Roma sarebbero stati risolti. In realtà quella proiezione aveva mostrato che il mondo non era più ordinato di Roma, e finiva con il riverberare su Roma i bagliori violenti del cesarismo e dello sfruttamento coloniale.
Ma Cicerone si salva passando dalla storia alla morale: è vero che la espansione di Roma nel mondo non ha portato all’instaurazione dell’ordine auspicato da Panezio; ma ciò è dovuto al fatto che la repubblica degli Scipioni è stata tradita, che l’ordine instaurato è non il vero ordine, bensì un dominio personale. Cicerone invoca qui una delle risorse tipiche della letteratura morale, che abbiamo già visto all’opera in Platone e Aristotele: la morale parla di un ordine che non esiste compiutamente, ma che dovrebbe esistere, e che in qualche modo e in qualche misura già esiste.
Per Platone e Aristotele la morale era la scienza che conduceva alla realizzazione del bene totale nel quale si compongono i beni parziali secondo una gerarchia conservata nell’anima, anche quando non esiste in realtà.
Per Cicerone la morale porta alla realizzazione di un ordine universale, che consiste nella generalizzazione dell’ordine e delle strutture già esistenti nelle nostre singole azioni. L’uomo per bene sa che nella sua vita la vera utilità deriva solo dalla virtù: se l’ordine della sua vita privata si generalizza, quella connessione non teme sfide e distruzioni.
LA DISEGUAGLIANZA TRA GLI UOMINI
Filosofi stoici forse meno brillanti di Panezio, come Diogene di Babilonia, Antipatro di Tarso, Ecatone di Rodi, meno legati anche alle grandi prospettive della politica romana, attraverso scolastiche discussioni di casistica, rifiutarono la connessione di virtù e utilità stabilita da Panezio. Cicerone avverte il problema, rimprovera a Panezio di non aver tenuto conto della casistica basata sull’ipotesi del conflitto tra virtù e utilità; ma di fatto non riesce a dar voce a questo problema. In realtà la virtù dell’uomo per bene è già soprattutto la tecnica di salvaguardare il proprio utile in un ordine che costituisce la protezione più efficace della posizione del gentiluomo. L’ordine della giustizia cosmica prevede che gli uomini siano diseguali, che ciascuno abbia la propria posizione, che nessuno minacci la posizione e la proprietà dell’altro: è chiaro che in questa situazione il miglior modo di provvedere all’utile consiste nel non far nulla che possa minacciare quell’ordine. Cicerone sa che, nel momento in cui scrive, la sua vita è minacciata e la virtù non lo protegge; ma la ragione di ciò sta nel fatto che l’ordine universale non si è realizzato. E tuttavia non c’è alternativa, perché fuori di quell’ordine l’uomo per bene non vedrà mai protette le sue proprietà e il suo decoro, la sicurezza dell’ordine sociale. Cicerone rifiuta di pensare che onesto e utile siano due cose diverse, che sia necessario scegliere la via dura e ambigua dell’utile o quella cristallina, ma povera, dell’onesto. L’utile a lunga scadenza vuole sicurezza, ordine, esige che ognuno stia al suo posto: e per ottenere questi risultati ci vuole l’onesto.
Quando la ‘polis’ classica stava per tramontare, Platone e Aristotele cercarono nella scienza lo strumento per scoprire dentro l’anima umana il modo in cui l’antica città avrebbe dovuto organizzarsi per sopravvivere.
Quando la ‘polis’ fu scomparsa i filosofi stoici cercarono una tecnica per proteggere l’uomo saggio in un mondo che andava diventando troppo ampio, ed elaborarono la tecnica della rinuncia calcolata. La loro morale divenne il modello di un uomo fatto in realtà per la società ellenistica, slegato dall’antica struttura delle ‘poleis’. Furono uomini come questi che elaborarono la filosofia di Roma come potenza mondiale, trasformando contemporaneamente la morale in una dottrina dell’ordine sociale generalizzato. Le vecchie rinunce stoiche furono smentite, l’ordine fu modellato sulle esigenze e sui bisogni della gente per bene del mondo ellenistico, gente fornita di proprietà, di schiavi, di belle cose, di decoro e bisognosa di sicurezza. Nella crisi della repubblica romana il quadro ottimistico sembrò compromesso, l’universalismo stoico sembrò insufficiente a fronteggiare l’emergere di conflitti personali, locali, di classe. Ma il “De officiis” di Cicerone portò una risposta a questo problema: finché l’ordine e la sicurezza non sono universali, onesto e utile sono in conflitto, perché la morale è la scienza che diventa del tutto reale solo quando è universale, solo quando i frammenti di ordine che si rivelano qua e là si compongono in un ordine universale. Nel frattempo l’uomo per bene deve fare solo ciò che mira alla realizzazione di quell’ordine, mantenendo decoro e proprietà.
IL DESTINO DEL “DE OFFICIIS”
Il “De officiis” fu un testo fortunato. I giuristi romani dell’età imperiale si ispirarono largamente a esso nell’interpretare il diritto come l’espressione e lo strumento di un ordine universale atto a garantire la collaborazione tra gli uomini in un sistema sociale fondato sulla sicurezza dei rapporti gerarchizzati, sulla difesa della proprietà, ma nello stesso tempo capace di assorbire i contrasti sociali. Anche il cristianesimo trovò modo di ricuperare come segno della provvidenza divina l’ordine morale al quale aveva fatto ricorso Cicerone. E la società moderna borghese, da Locke a Immanuel Kant, trovò nel “De officiis” un testo di morale ancora ampiamente utilizzabile. Ancora una volta un programma non realizzato, proposto nel momento in cui il suo fallimento risulta evidente, come strumento per risolvere una crisi mortale, si presentava come un corpo di regole ideali capaci di proporre un modello alla società futura. In realtà quelle regole diventavano lo strumento per legare a una tradizione culturale e a una situazione del passato una realtà presente, con la sua ansia di sicurezza, con il bisogno di creare un sistema capace di assorbire i contraccolpi dei contrasti sociali, un sistema in cui un signore romano possa badare ai suoi beni ed esser considerato un uomo per bene, di animo buono e di modi decorosi.
.
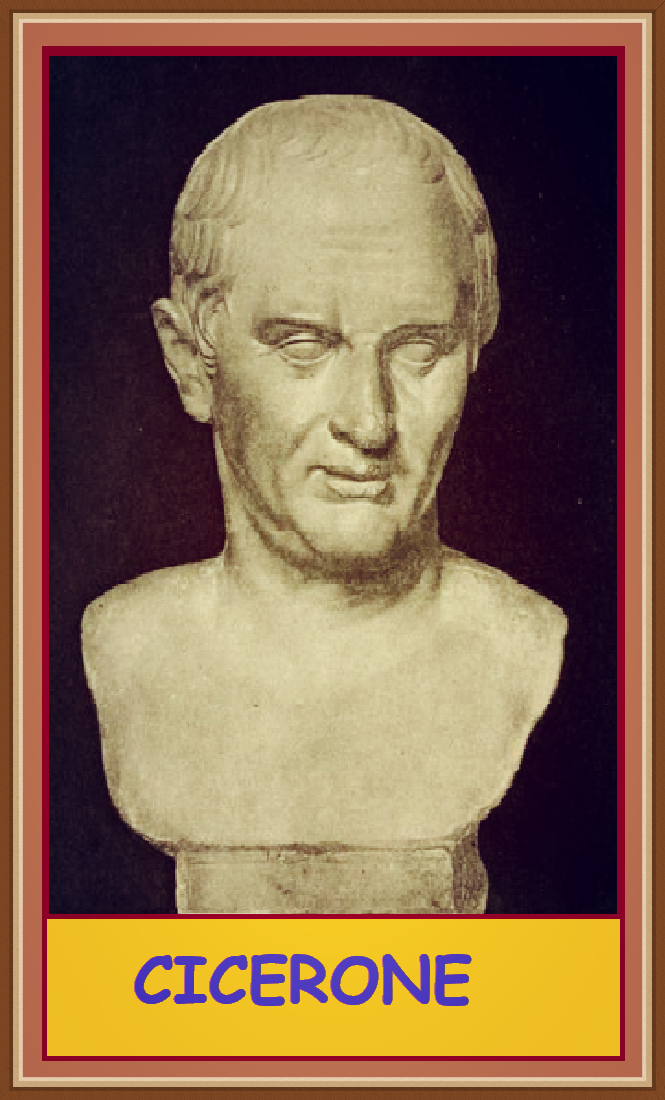
.
VEDI ANCHE . . .
MARCO TULLIO CICERONE – Vita e opere
L’ORAZIONE IN DIFESA DI ARCHIA – Cicerone
LETTERE (Epistolario ciceroniano) – Marco Tullio Cicerone
LETTERE SCELTE – Cicerone
LETTERE AI FAMILIARI – Cicerone
LETTERE ROMANE – Epistole al fratello Quinto – Cicerone
LETTERE AD ATTICO – Marco Tullio Cicerone

