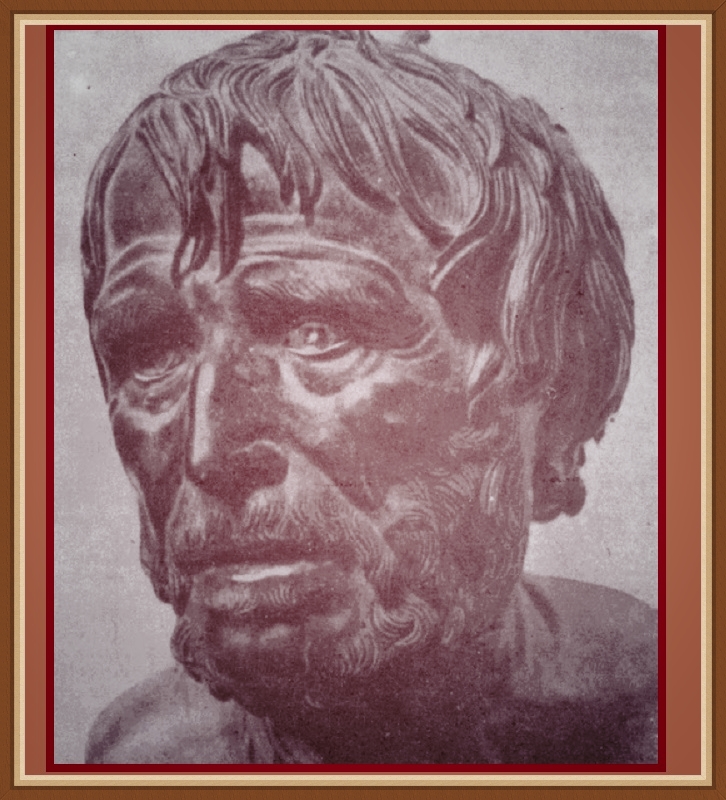Seneca e la crisi della morale universale
.
Il filosofo Seneca, considerato uno dei grandi maestri della tradizione morale occidentale, esordì nella trattatistica filosofica con una “Consolazione a Marcia”, composta forse tra il 37 e il 40 d. C.
La “consolazione” era un genere letterario largamente praticato nella cultura ellenistíca. Aveva raggiunto la forma canonica con l’accademico Crantore nel IV sec. a.C. e aveva una struttura fissa. Serviva a consolare il destinatario della morte di qualche persona cara esortando alla filosofia, intesa come scoperta e considerazione di un ordine nel quale anche la morte e il dolore tendono a perdere significato.
Nel mondo romano Cicerone aveva trattato il genere consolatorio, non a caso una delle sue fonti era stato il “Protreptico”, l’opera perduta nella quale Aristotele esortava un principe alla filosofia. Non risulta che in quest’opera Aristotele avesse preso lo spunto dalla morte di qualcuno; ma forse nelle opere perdute Grillo e Eudemo Aristotele doveva collegare morte e filosofia.
Questo collegamento risaliva addirittura al “Fedone” di Platone, il dialogo nel quale paradossalmente Socrate consolava gli amici della propria morte imminente, e presentava la filosofia come preparazione alla morte e culto dell’anima.
Nel passaggio da Platone alla letteratura ellenistica il collegamento di morte e filosofia aveva progressivamente perso il significato di ricerca di una giustizia alternativa a quella di Atene, che aveva condannato Socrate, per diventare l’esaltazione di un ordine già presente nella realtà, al di là dei suoi aspetti dolorosi, o la denigrazione dei beni caduchi come semplici vanità.
.
Proprio a quest’ultimo tema si rifaceva Seneca.
Era nato in Spagna qual che anno prima di Cristo (4 a.C.), da un letterato illustre, era venuto a Roma, aveva ricevuto un’educazione filosofica tutta romana, perché intorno al 18-20 d.C. aveva frequentato la scuola filosofica fondata a Roma da Quinto Sestio e continuata per breve tempo dal figlio.
Non sono molto informato su questa scuola; ma, non fosse altro che da un maestro erudito come Sozione di Alessandria, che vi insegnava, Seneca dovette apprendervi le varie tradizioni filosofiche, così come dovette ricevere una buona educazione letteraria, storica e scientifica, perchè i Sestii probabilmente si ispiravano allo stoicismo enciclopedico di Posidonio.
La donna alla quale Seneca indirizzava la sua prima consolazione era figlia dello stoico Cremuzio Cordo, che si era ucciso sotto Tiberio, perseguitato da Seiano perché aveva scritto certi “Annali” troppo liberi.
Caligola, salito al trono, aveva autorizzato la pubblicazione dell’opera sospetta, che Marcia aveva preparato per la pubblicazione; a questa Marcia, colpita dalla perdita di un figlio, Seneca rivolgeva la propria consolazione.
L’esordio di Seneca avveniva pertanto nella cerchia dello stoicismo romano, legato all’opposizione imperiale quale si era andata configurando soprattutto sotto Tiberio.
Caligola sembrò meno preoccupato dell’opposizione intellettuale stoicheggiante, Marcia poté pubblicare l’opera del padre, Seneca tentò la vita politica attiva. Si disse che questo tentativo avesse destato i sospetti imperiali: Seneca si ritirò a vita privata, ma rimase molto legato alla corte attraverso Giulia sorella di Caligola.
.
Quando Claudio divenne imperatore l’amicizia con Giulia danneggiò Seneca che dal 40 al 49 fu esiliato in Corsica. L’esilio è sullo sfondo di altre due consolazioni di Seneca, una scritta tra il 42 e il 43 alla madre Elvia, afflitta dall’esilio del figlio e dalla morte del marito, e l’altra, scritta tra il 43 e il 44 a Polibio per consolarlo della morte di un fratello; Polibio, liberto di Claudio, avrebbe potuto farlo ritornare a Roma.
A Roma infatti Seneca tornò colmo di onori e potenza, chiamato da Agrippina, seconda moglie di Claudio, per diventare precettore del giovane Domizio e per guidare la politica imperiale quando questi sarà diventato l’imperatore Nerone.
.
Lo stoicismo come filosofia romana legava in qualche modo Seneca a Cicerone, anche se molte cose nel frattempo erano cambiate, la repubblica romana era finita, dall’impero di Augusto si era passati a quello di Caligola e Claudio, l’antica Stoà greca aveva praticamente finito di esistere e Seneca aveva già studiato in una scuola tutta romana.
Anche Seneca aveva in qualche modo incominciato con il riflettere nelle proprie opere filosofiche le vicende pubbliche, soprattutto le pubbliche sventure.
Dietro le disgrazie private per le quali Seneca dispensava consolazione, c’erano l’impero di Tiberio e il governo di Seiano, la figura dell’imperatrice Messalina, dell’imperatore Claudio.
Ma lo stoicismo di Seneca era ben diverso da quello di Cicerone.
Questi metteva in primo piano i problemi pubblici, e vedeva nello stoicismo di Panezio una filosofia pubblica, capace di dare il piano di un ordine morale universale, che la repubblica romana avrebbe ancora potuto realizzare. Cicerone era ben consapevole della debolezza dell’ordine politico per il quale era vissuto, ed era convinto che solo un rinnovamento morale, capace di fare del governo di Roma un ordine nel quale ci fosse posto per tutti, ciascuno nella propria posizione, avrebbe potuto salvare la repubblica e i1 suo impero nel mondo.
Nel momento in cui Seneca scriveva, l’impero romano si era salvato; la vera vittima era stato l’ordine senatorio, con il quale Cicerone aveva identificato il destino di Roma, e ora lo stoicismo rischiava di essere l’arcigno rimpianto di un tempo finito.
.
In questa prospettiva bisogna collocare la morale di Seneca.
Essa non è più la morale politica, l’ispiratrice di regole che possono essere immediatamente trasferite in leggi; al contrario è una morale privata, aperta a ciascun uomo, indipendentemente dalla sua condizione, ma non proponibile a una comunità politica.
A Marcia, afflitta dalla morte del figlio, Seneca dichiara “che non è naturale esser tormentati dai lutti”, e, poiché ciò che non è naturale non dura, “la sua stessa durata uccide il dolore”.
Ciò che è naturale è uniforme, ciò che è vario è dovuto alle consuetudini; i lutti, i dolori, gli affanni sono vari, e perciò son dovuti alle consuetudini: è facile liberarsi da essi, come è facile liberarsi dalle consuetudini.
L’uomo è un essere debole, esposto a tutti i dolori, le delusioni, le sofferenze, minacciato dalla morte; la sua salvezza consiste nel liberarsi dalle attese che poggiano solo sulle sue forze precarie: dunque la morte non è un male, perché è la liberazione definitiva.
Vuol convincere la madre Elvia che l’esilio non è un dolore invincibile. L’amore per la patria e per Roma non ha senso in una prospettiva universale: la legge universale e la necessità naturale hanno sparso gli uomini dappertutto, e Roma stessa ha radunato uomini di paesi lontani mentre ha radunato uomini di paesi lontani mentre ha mandato i suoi figli in terre lontane e ignote.
E’ inutile cercare nelle leggi e nelle consuetudini degli uomini il criterio dei beni e dei mali: questi sono molto superiori al potere dello uomo, e l’uomo può solo con il proprio animo difendersi dalle avversità e trasformare in beni le sventure.
A Polibio, il potente liberto dell’imperatore, che vive nel fasto della capitale, Seneca ricordava che tutto è caduco, anche i monumenti più saldi: non lo diceva esplicitamente, ma faceva intendere che pensava anche a Roma. Per consolarlo della morte del fratello, gli ricorda ancora una volta che fati, natura, fortuna sono insensibili alle aspettative umane, che l’uomo è troppo debole per poter sperare di essere felice, che la morte è il più sicuro dei rifugi. Tutto nella vita è senza senso: gente che si affanna, che si muove frenetica per il mondo, senza scopo, oppressa da dolori.
.
In un’opera dedicata all’ira Seneca conduceva una critica radicale di tutta la vita emotiva umana. Si sa che quello delle emozioni è un tema importante della morale antica: i grandi classici del IV sec., Platone e Aristotele, avevano sostenuto che le emozioni in qualche modo hanno un valore morale e i “beni esterni”, ai quali esse sono legate, sono ricuperabili, mentre le scuole successive, dagli stoici agli epicurei, avevano sostenuto che la morale autentica deve prescindere
dalle emozioni legate ai beni esterni. Ai difensori della vita emotiva l’ira era sembrata l’emozione più nobile: essa mobilita le forze spirituali dello uomo quando gli si manifesta l’ingiustizia sotto la specie di un torto subito.
Seneca si attiene all’antico precetto stoico, che l’ira, in quanto emozione, deve essere evitata, perché l’ingiustizia può essere evitata o punita o neutralizzata con altri mezzi, puramente razionali.
Ma mentre lo stoicismo di Panezio e del suo scolaro Posidonio aveva in qualche modo cercato di ricuperare le forme di vita che si manifestano attraverso le emozioni, Seneca è su questo punto intransigente e ritorna ai precetti dello stoicismo originario. Gli uomini mossi dall’ira nelle piazze e sui campi di battaglia, nei tribunali e nella vita privata sono schiavi dei vizi. Se l’ira, la più nobile delle emozioni, è un travisamento della giustizia, tutta la vita giornaliera, la vita politica, quella che si vive nel foro, è pura follia. Il sapiente autentico deve disimpegnarsi dalla vita pubblica, deve staccarsi dai beni sociali e legati al corpo, perché essi sono caduchi. La vita di tutti i giorni e di tutti, con le sue regole, i suoi puntigli, le sue competizioni, è per il sapiente follia, impegno con beni falsi e apparenti. Il sapiente si stacca da quella vicenda, che dal punto di vista della ragione è senza senso.
Posidonio, il più grande rappresentante dello stoicismo universalistico di Panezio, filosofo, scienziato e storico, aveva cercato di ricomprendere nella visione stoica tutti gli aspetti della vita umana. La ragione stoica, nelle sue mani, diventava lo strumento per ricomporre le fila di un grande disegno provvidenziale nel quale rientra tutto, dai grandi fenomeni astronomici agli imperi, dalle scoperte geometriche alla magia. In quel disegno anche l’impero romano aveva un posto.
Cicerone conobbe Posidonio, e da lui apprese una certa utilizzazione del patrimonio ideale stoico. Ma quando gli ideali imperiali della classe senatoriale rappresentata da Cicerone si furono realizzati nella forma dell’impero di Augusto, quando il principato di Augusto fu sostituito da quello di Tiberio, lo stoicismo politico romano non si riconobbe più nella nuova realtà politico-sociale.
Via via che l’impero universale diventava una realtà, e non soltanto l’ideale di un oratore filosofo, l’evasione verso il futuro come unica alternativa alla morte della repubblica, gli eredi intellettuali dello stoicismo non riconoscevano più nell’impero romano il regno della ragione. Sembrava che Roma potesse mettere a disposizione di tutti gli uomini i tesori intellettuali che lo stoicismo aveva elaborato per il sapiente; e invece sotto l’impero di Augusto lo stoicismo rinasceva come scuola di élite, alla quale possono sì accedere uomini di ogni condizione, ma che presuppone la possibilità della liberazione dalle cure di ogni giorno.
Quando, probabilmente tra il 55 e il 56 d.C., scrisse “La clemenza”, indirizzata a Nerone diventato da poco imperatore e del quale sarebbe stato consigliere politico fino al 60, Seneca ha già accolto pienamente la figura ellenistica del sovrano assoluto, investito di un destino cosmico, materializzazione della necessità cosmica; ma la sua virtù caratteristica è non la giustizia, bensì la clemenza, perché i sudditi non sono protagonisti e membri di un ordine universale, bensì poveri uomini coinvolti in una vicenda violenta e senza senso, che hanno bisogno di essere beneficati e di essere guardati con indulgenza dal loro sovrano.
Seneca guardò con simpatia al cinismo e all’epicureismo, nel quale Cicerone aveva visto una filosofia privata poco adatta a un uomo pubblico romano. Ma ora Seneca poteva condividere uno dei principi di Epicuro: la morale comune, con le sue aspettative e le sue illusioni, è sbagliata, è parte della vicenda violenta della natura. Il filosofo non deve purificare, perfezionare, generalizzare la morale comune per ottenere la vera morale universale; al contrario deve fuggire la morale comune, non riconoscersi in ciò che gli altri uomini vogliono. Posidonio sbaglia quando dice che i sapienti hanno beneficato l’umanità con l’invenzione delle arti: la ricchezza materiale ha reso gli uomini peggiori. Certo c’è la provvidenza divina, ma essa assiste gli uomini dando loro uno spirito nel quale trovare rifugio contro le avversità.
Alla morale filosofica e razionale, che cerca di generalizzare le regole seguite da tutti gli uomini, per eliminare quanto di falso c’è nella morale corrente, si sostituisce una morale della salvezza degli eletti, del tutto staccata dalla condotta degli uomini comuni, intesa come il mezzo per salvarsi nell’interiorità dai mali della vita.
Il caso, la fortuna dominano le vicende umane, ma la provvidenza divina ha dato all’uomo la possibilità di ritirarsi nella propria interiorità e di sfuggire ai mali della vita.
Qualche volta un imperatore, un potente della terra può anche essere benevolo e clemente, ma può anche trasformarsi in un tiranno, in un collerico dio mortale.
Tra il potente e il sapiente la folla degli uomini oppressi dai loro mali e dalle loro pazze emozioni: dietro le opere morali di Seneca s’intravede l’impero romano uscito dalle crisi sociali della repubblica, dalle conquiste militari, dall’assorbimento dei modelli ellenistici.
Roma è diventata la capitale del mondo, ma anche il centro nel quale gli uomini di tutte le parti del mondo portano le loro insensate ambizioni o la loro disperata incapacità di sottrarsi al dolore. Il foro non è più il tempio solenne dove si celebrano i riti della giustizia universale, è piuttosto un palcoscenico sul quale si esibiscono tutte le superstizioni.
Un romanziere contemporaneo di Seneca, Petronio, ha descritto nel “Satyricon” questa umanità.
.

Statua di Seneca a Cordova
.
Sulla via aperta da Seneca si porrà ormai lo stoicismo imperiale, slegato dalle grandi tradizioni ateniesi, diventato l’ideale di una vita privata, anche quando non sarà osteggiato dalla corte.
Dopo che Nerone si fu liberato di Seneca (65 d.C.), travolto nella repressione seguita alla scoperta della congiura di Pisone, i filosofi stoici conobbero l’esilio, e tra essi Musonio Rufo, personaggio eminente dello stoicismo romano.
Da Tiberio a Domiziano per tutto il I sec. d.C. i filosofi romani dovranno subire l’alterna politica della corte imperiale, che vede nella tradizione stoica la giustificazione di un impero diverso da quello militare che di fatto ha preso il potere. E la progressiva “privatizzazione” dello stoicismo romano è anche una risposta e una difesa nei confronti della politica imperiale.
Alla corte di Nerone, schiavo del potente liberto imperiale Epafrodito, c’era uno scolaro di Musonio Rufo, destinato a continuare le sorti dello stoicismo.
Epitteto, liberato, poté tener scuola a Roma, fino a quando, cacciato dal bando di Domiziano nel 94 d.C., si stabilì in Epiro.
Arriano, suo scolaro, ci ha tramandato il suo insegnamento orale, trascrivendo fedelmente le sue lezioni, dalle quali trasse anche un Manuale, diventato uno dei testi fondamentali della nostra tradizione culturale.
.
Epitteto teorizzò essenzialmente la intangibilità della coscienza: l’uomo può esser colpito in ogni cosa, nel corpo, negli averi, nella reputazione, nella libertà esterna, ma nessuno può raggiungere la sua coscienza.
L’importante è non contrarre impegni con le cose che non dipendono da noi, cioè che non sono comprese nella sfera della coscienza.
I confini della coscienza sono i confini dell’intangibilità dell’uomo, perché un atto di coscienza può interagire solo con un altro atto di coscienza, e nessuno dall’esterno può amministrare gli atti della coscienza.
L’allievo ideale di Epitteto fu Marco Aurelio, diventato imperatore nel 161 d.C.
Epitteto aveva goduto le simpatie di Adriano e Adriano aveva in qualche modo scelto Marco Aurelio per il trono imperiale. Lo stoicismo “privato” di Seneca arrivava così al potere. Ma ormai esso era diventato una filosofia della coscienza.
L’imperatore Marco Aurelio scrisse un’opera in greco intitolata “A se stesso”: come filosofo egli era un privato, che scriveva non nella lingua di Cicerone, che considerava la filosofia romana un fatto pubblico, ma nella lingua della tradizione politicamente vinta, e che si rivolgeva a se stesso, come uomo singolo, cui pure è toccato il potere imperiale.
.
La morale antica si era costituita con le grandi scuole filosofiche ateniesi del IV sec. a.C. come teoria scientifica della virtù, cioè delle qualità che spettano all’uomo in quanto uomo, vale a dire in quanto essere che ha un’anima e che è in grado di prendere decisioni in una comunità. In seguito il legame tra teoria morale e considerazione della comunità si era attenuato, e si era preferito vedere nella morale la teoria della virtù come qualità propria dell’uomo che si fa governare solo dall’anima razionale; poi era stato ricuperato il riferimento alla società, e la morale era diventata la teoria dei comportamenti che rientrano in un ordine universale.
Ma dopo la crisi della repubblica romana e la fondazione dell’impero lo stoicismo romano vedeva nella coscienza il fondamento della morale: questa è l’insieme dei precetti che permettono di riconoscere i comportamenti che si possono praticare senza uscire dal cerchio della coscienza, e dentro la coscienza non è che bene.
E’ un principio che agirà potentemente nella nostra tradizione culturale, con significati spesso diversi, talora opposti: potrà essere il fondamento per la rivendicazione della libertà e dell’indipendenza, potrà essere un criterio per liberarsi dalle conseguenze dei propri atti.
Nella storia dell’impero romano la dinastia degli Antonini rappresentò il tentativo di uscire dalla spirale del potere militare nella quale l’impero poteva essere travolto e lo sforzo di fare dell’impero una costruzione amministrativa e civile: lo stoico Marco Aurelio si considerò in un certo senso il primo funzionario e servitore dell’impero.
L’appello alla coscienza in questo contesto agiva proprio come principio di correttezza degli atti nella misura in cui dipendono, all’origine, da chi li fa e come mezzo di liberazione dalle loro conseguenze, in un mondo che sembrava diventato troppo grande per essere ancora padroneggiato dall’uomo.
Lo stoico privato ha la attrezzatura spirituale per diventare il funzionario di una grande macchina della quale è smarrito il piano generale, si preoccupa dei comportamenti per quanto riguarda la sua coscienza e in essa cerca scampo quando gli rimbalzano contro.
A di là di esso si muovono gli uomini che hanno a cuore soprattutto le conseguenze, affaristi, ambiziosi, avidi di potere, o gli uomini che non possono trascurare le conseguenze esterne dei comportamenti, i poveri, gli schiavi, gli affamati.
.

.
VEDI ANCHE . . .
LUCIO LINNEO SENECA – La crisi morale universale
EDIPO (Oedipus) – Seneca (Tesauro – Thesaurus)
GLI SCHIAVI SONO UOMINI COME NOI . “Lettere a Lucilio” – Seneca
EDIPO RE (Oedipus Rex) – Sofocle
ANTIGONE – Sofocle
EDIPO RE – Pier Paolo Pasolini